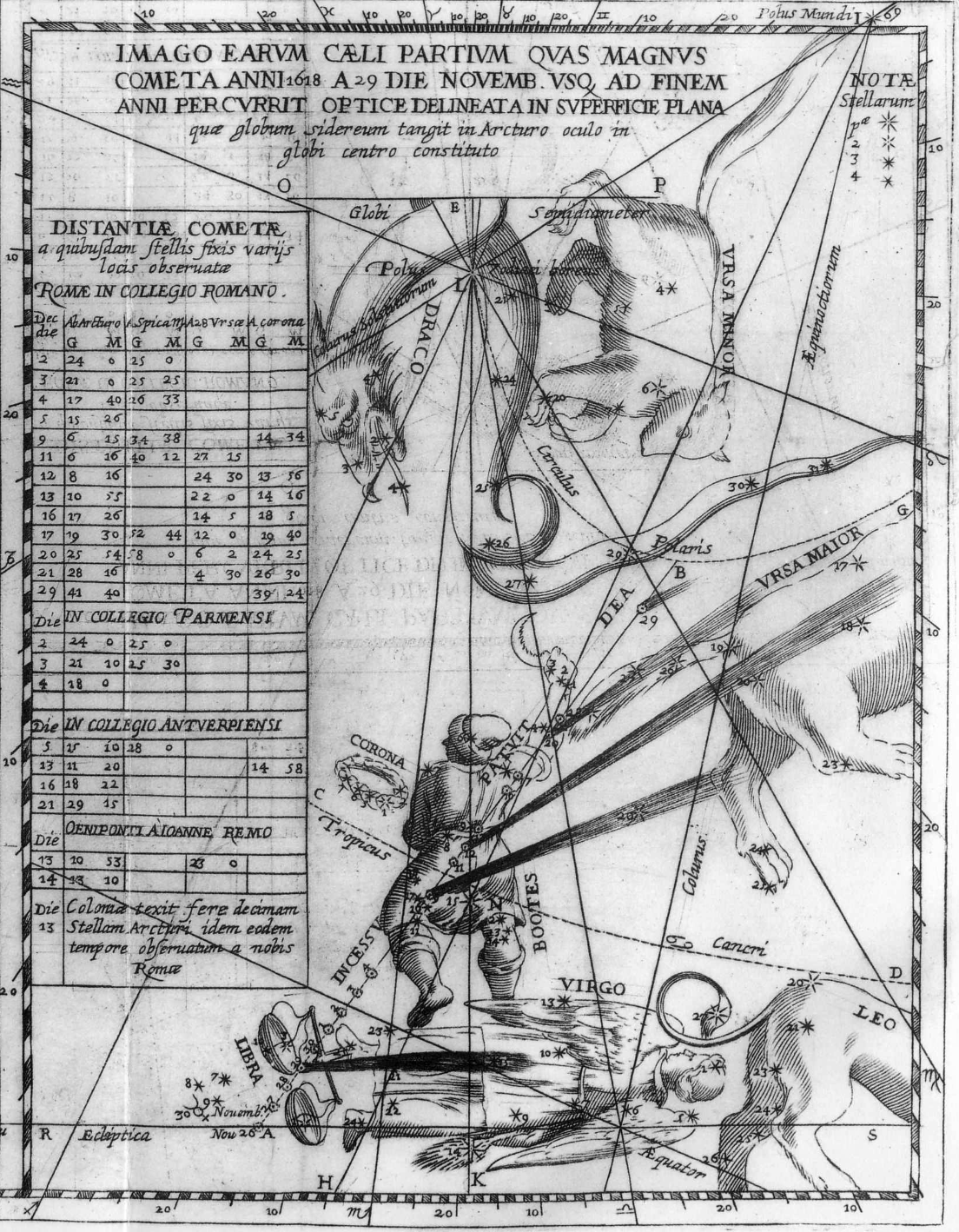I’m interested in anything about revolt, disorder, chaos,
especially activity that appears to have no meaning.
It seems to me to be the road toward freedom.
Jim Morrison
L’idea secondo cui il testo di una canzone possa essere considerato e analizzato come un testo letterario, nello specifico di tipo poetico, passibile, pertanto, di interpretazioni, trova concordi molti studiosi. Fra i tanti, è proprio uno scrittore, Pier Vittorio Tondelli, a riconoscergli questa legittimità affermando:
Il bisogno di poesia, bisogno assoluto e struggente negli anni della prima giovinezza è stato soddisfatto da intere generazioni mandando a memoria parole e strofe di canzoni: ballate pop, testi psichedelici, neofuturisti, intimisti, sentimentali, onirici, politici, ironici, demenziali, mentre la poesia colta rimaneva territorio di interpretazioni, esegesi, svolgimenti noiosi sui banchi di scuola.
All’interno di questo contesto, nonostante sia troppo spesso snobisticamente definita “canzonetta”, un ruolo molto importante è riservato alla musica pop, per l’enorme impatto e potenzialità che questa ha nella vita quotidiana. Come, infatti, Gino Castaldo, critico musicale della «Repubblica», sottolinea: «Da chiunque venga immaginata, una canzone prende vita solo quando dalla bocca del cantante discende in mezzo alla gente, quando viene amata, usata, sgualcita, imbrattata di realtà, reinventata nei rigagnoli delle mille occasioni quotidiane e dalla potenza del sentimento collettivo».Le canzoni, dunque, come sostiene Lorenzo Coveri, fungono «da “traduttori culturali”, in grado di filtrare esperienze letterarie e novità linguistiche e di trasmetterle al pubblico di massa, […] [e sono] sempre più specchio, sempre meno modello, della complessa realtà linguistica e culturale dell’Italia di oggi».
Fatta questa breve premessa, vorrei spendere due parole sul corpus – per ragioni di spazio certamente limitato – delle canzoni scelte: si tratta, per lo più, di hit di successo, con il denominatore comune di essere state eseguite, talvolta scritte, da artiste. E questo non solo perché le cantanti italiane, analogamente a quanto avviene in altri ambiti artistici, sono meno studiate e meno presenti, per esempio nei volumi che riguardano la storia della canzone italiana, ma anche per i particolari spunti che offrono per l’analisi in questione. Come afferma il paroliere Gianfranco Baldazzi, «alla donna che canta è delegato il ruolo di cartina di tornasole dei mutamenti di costume. Più spesso di quanto faccia l’interprete maschile, la donna aggiunge, alla canzone che canta, un’immagine che tende a evidenziarsi come unica: è portatrice, anche a livello gestuale, di novità». Gli fa eco, ancora, Coveri che asserisce: «la canzone ha a che fare, più che con un atto di comunicazione orale, con un atto di comunicazione teatrale». La canzone, dunque, non è solo un atto linguistico, musicale o vocale ma anche gestuale.
Sempre con l’obiettivo di restringere il campo, mi riferirò essenzialmente al periodo musicale a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, periodo in cui, in un’Italia senza governi stabili e nel pieno di un’intensa crisi economica, ci si misura con gli anni di piombo, l’assassinio di Aldo Moro, la tragedia di Ustica, lo scandalo P2 e i numerosi omicidi di mafia. C’è bisogno di svago e lo si trova nelle nuove emittenti televisive e radiofoniche private, inizialmente regionali, poi anche nazionali, nelle prime televisioni a colori, nel moltiplicarsi delle discoteche.
Anche la musica si colora e fa il suo percorso. Comincia, infatti, un rinnovamento musicale che accompagna costumi, consumi e abitudini di una consistente fetta d’Italia, nello specifico quella al femminile, stanca di madri, mogli o amanti in eterna attesa di mazzi di rose. In particolare, dal 1977 si sviluppano, sulla scia della tradizione anglo-americana e in rottura con la tradizione melodica italiana, il punk-rock e il rock demenziale, in cui, tra provocazione e ironia, prendono corpo forme musicali che alla verbosità cantautorale e al sentimentalismo diffuso oppongono ritmi incalzanti ed esibizioni provocanti, non prive di ammiccamenti erotici e sensuali.
In questo processo vengono coinvolte, soprattutto, le cantanti: del resto, se le donne appaiono fra i soggetti più interessati dalla liberazione dei costumi sessuali, ciò accade proprio perché a loro la vecchia morale aveva sempre negato un rapporto sereno con il corpo. Osserva Emiliano Longo, autore di un illuminante saggio sulla poetica di Donatella Rettore:
In particolare la donna, che subito dopo la guerra era stata relegata entro le mura domestiche, confinata in ruoli tradizionali all’interno della famiglia e sostanzialmente esclusa dalle attività professionali, accelerando bruscamente un processo già in atto da almeno due secoli, cambia “drammaticamente” il proprio modo di pensare e il proprio atteggiamento, ingaggiando una sfida al “maschio dominante”, al fine di ottenere un riposizionamento equilibrato del proprio ruolo.
Saltato il tappo, troppo compresso fino ad allora, è un pullulare di esibizioni musicali, veramente degne di spettacoli teatrali: avvenenza fisica, presenza scenica, abbigliamento stravagante, stile disinibito, modi anticonformisti, carica erotica si coniugano con un’inedita capacità di giocare in modo dissacratorio con le parole e con il corpo. Di qui i numerosi travestimenti, non solo come una moda del tempo, ma come un’esigenza interiore, personale, di non fissarsi, direbbe Pirandello, in forme stabili, rimettendosi continuamente in discussione, attraverso la fantasia e l’immaginazione creativa e contro l’appiattimento o i problemi della vita quotidiana. In una celebre conferenza-radio del 1966, Michel Foucault, interrogandosi sulla relazione fra corpo e spazio in vari ambiti, scorge nel travestimento un modo per entrare in comunicazione, attraverso l’“altro”, con il soprannaturale:
Mascherarsi, truccarsi, tatuarsi non significa, come ci si potrebbe immaginare, acquistare un altro corpo, un po’ più bello, più decorato, più facilmente riconoscibile; tatuarsi, truccarsi, mascherarsi è certamente un’altra cosa, è fare entrare il corpo in comunicazione con poteri segreti e forze invisibili. La maschera, il segno tatuato, il trucco, depositano sul corpo tutto un linguaggio: tutto un linguaggio enigmatico, tutto un linguaggio cifrato, segreto, sacro, che richiama su quel corpo la stessa violenza del Dio, la potenza sorda del sacro o la vivacità del desiderio. La maschera, il tatuaggio, il trucco mettono il corpo in un altro spazio, lo fanno entrare in un luogo che non ha immediatamente luogo nel mondo e fanno di quel corpo il frammento di uno spazio immaginario che comunicherà con l’universo delle divinità o con l’universo altrui. Saremo afferrati dagli dei o dalla persona che abbiamo appena sedotto. Comunque la maschera, il tatuaggio, il trucco sono operazioni con cui il corpo viene strappato al proprio spazio e proiettato in un altro.
Certo, già a metà degli anni ’60, Caterina Caselli non mostrava nessuna esitazione, in Nessuno mi può giudicare, a scegliere fra due l’uomo a cui “abbracciarsi”: «Se sono tornata a te / Ti basta sapere che / Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te».
Dieci anni dopo, Loredana Bertè lanciava sul mercato Streaking, un concept album dalla copertina censurata, sulla sessualità vissuta in maniera libera e provocatoria, dato che il termine indica la pratica esibizionista di irrompere completamente nudi in manifestazioni pubbliche; e, naturalmente, Mina che, in L’importante è finire (1975) e Ancora Ancora Ancora (1978), canzoni di Cristiano Malgioglio entrambe censurate, fa riferimento esplicito a un amplesso amoroso:
Io ti chiedo ancora
La tua bocca ancora
Le tue mani ancora
Sul mio collo ancora
Di restare ancora
Consumarmi ancora
Perché ti amo ancora
Il ruolo della donna è, tuttavia, quello tradizionale dell’amante innamorata e tentata, che chiede e cede a un uomo dominatore: di certo un legame ben diverso da ciò che già nel 1973, in Pazza Idea, cantava Patty Pravo, ovvero la scabrosa situazione del far l’amore con un uomo, pensando a un altro:
Pazza idea di far l’amore con lui
pensando di stare ancora insieme a te
Folle, folle, folle idea di averti qui
mentre chiudo gli occhi e sono tua
Pazza idea, io che sorrido a lui
sognando di stare a piangere con te
Folle, folle, folle idea sentirti mio
se io chiudo gli occhi vedo te.
È tuttavia nel 1978 con Pensiero Stupendo, scritto da Ivano Fossati, brano di triangolo amoroso, scambi di amanti, ebbrezza e di amplessi “inconsueti”, che la cantante veneziana lascia una traccia indelebile: «E tu, e noi, e lei fra noi; / le mani, le sue / e poi un’altra volta noi due…». L’artista, infatti, la interpreta con sublime perversione, mostrandosi anche con una nuova immagine futurista e fetish: increstata in testa, occhi bistrati, sguardo stralunato, scollature vertiginose, un look con cui scandalizzerà le prime serate televisive italiane. Dello stesso album si potrà anche apprezzare il delirio lascivo di Johnny, in cui si canta di una donna che decide di ricorrere ai “servizi” di un gigolò:
Johnny fammi la festa
vai mio bel gigolò
e a dispetto di me stai implorando
e con il senno del poi stai desiando.
Un anno dopo, nel 1979, la senese Gianna Nannini raggiungeva il successo con America, scritta da lei stessa:
per oggi sto con me,
mi basto e nessuno mi vede
e allora accarezzo la mia solitudine
ed ognuno ha il suo corpo
a cui sa cosa chiedere chiedere chiedere chiedere.
Fammi sognare lei le mani sui fianchi come fosse l’America
Fammi volare lui che scende e che sale e si sente l’America
Fammi l’amore lei che pensa ad un altro e si inventa l’America
Fammi l’amore forte sempre più forte ed io sono l’America.
La canzone, naturalmente, non aveva nulla a che fare con l’America e, su un ritmo molto solido sottolineato da chitarre rock vagamente distorte, era un chiaro inno alla masturbazione. Non a caso, la copertina del disco mostrava la statua della libertà che, invece di tenere in mano la fiaccola, reggeva un vibratore, un chiaro attacco al perbenismo e agli americani.
Le farà eco, sullo stesso tema, Fiorella Mannoia che, nel 1981, sull’austero e tradizionalista palco di Sanremo, si esibirà con la canzone Caffè Nero Bollente, su testo di Mimmo Cavallo:
Ma io come Giuda so vendermi nuda
da sola sul letto mi abbraccio mi cucco
malinconico digiuno senza nessuno
Io non ho bisogno di te perché io non ho bisogno di te
io non ho bisogno di te perché io non ho bisogno delle tue mani
mi basto sola.
Quattro anni dopo, in L’Aiuola, la Mannoia rivolgendosi all’amato, gli chiederà perché «fai morir l’aiuola?». L’allusione sessuale sembra lecita, dal momento che, anni dopo, con lo stesso titolo, ritroveremo l’aiuola in una canzone di Gianluca Grignani come chiaro simbolo sessuale.
Tornando al repertorio al femminile, sempre nel 1978, ancora Fossati scrive per Anna Oxa Fatelo con me con un testo di sottomissione sadomaso prima sussurrato, poi sempre più aggressivo.
Normalmente è facile perché non grido
Dura a lungo è garantito perché non mi muovo
Provate con me ciò che volete fare
Provate con me smettete di sognare
Fatelo con me… su di me!
Ma la lista di canzoni “ardite”, in questo periodo, non finisce qui: da Viola Valentino, che in Comprami (1979) si propone a un uomo particolarmente sfortunato in amore, a Raffaella Carrà che, in veste di cantante, in Tanti Auguri (1978) esalta il sesso in tutte le sue forme, «in campagna ed in città», come soluzione a odio e guerre. E ancora: Ti sento dei Matia Bazar (1985); Ti Voglio di Ornella Vanoni (1977); Violentami sul metrò di Jò Squillo (1981); Cocktail d’amore di Stefania Rotolo (1979), Ho fatto l’amore con me (1980) di Amanda Lear, le ultime due scritte da Cristiano Malgioglio.
Un posto a parte merita, però, Rettore. Reduce dal successo di Splendido Splendente, in cui la cantautrice veneta fa riferimento, con straordinario anticipo sui tempi, a concetti di fluidità di genere («come sono si vedrà, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità») nel 1980 incide Kobra, brano in cui, probabilmente, l’ironia e l’ostentazione della tematica sessuale trovano l’espressione più completa e audace, trattandosi di una canzone che, più delle altre, contiene ben più che un’allusione.
Qui, infatti, si parla dell’organo sessuale maschile identificato con il kobra e definito: «un pensiero frequente che diventa indecente» e «un nobile servo che vive in prigione». “Servo” e “Pensiero frequente” di chi? Dell’io narrante o, meglio, dell’“io cantante” e, più in generale, della donna che apertamente rivendica così il suo ruolo attivo nella sessualità. Ma la canzone, vincitrice del popolarissimo Festivalbar, va oltre, descrivendo, nel ritornello, la dinamica di un rapporto sessuale:
Il kobra si snoda
Si gira, mi inchioda
Mi chiude la bocca
Mi stringe e mi tocca…
Ma non basta. Nello stesso LP, Magnifico Delirio dello stesso anno, abbondano i richiami alla sessualità, anche in altri brani: da Gaio, in cui si fa riferimento a una transgender, a Benvenuto, dedicata al sesso orale il cui videoclip, inizialmente previsto come sigla di Domenica In, è stato censurato per eccesso di “ammiccamenti”. Non a caso il critico musicale Gianni Borgna osserva a proposito dell’artista: «La Rettore sa esibire l’osceno con tanta arguzia da apparire quasi innocente».
Riprendendo le parole di Paola Tirone e Paolo Giovannetti, si potrebbe identificare nelle canzoni di queste artiste una certa «eterodizione consumistica» in cui, cioè, dietro una facciata astrattamente massificata che inevitabilmente le canzoni pop presentano, si ravvisa un’innegabile potenzialità eversiva. In tal modo, normalità e protesta, conformismo e antagonismo sembrano avvicendarsi e, ad ogni istanza conformistica e omologante, si accompagna sempre un empito di trasgressione disordinata degli equilibri esistenti nell’immaginario collettivo.
E questo non vale solo per i testi: va, infatti, detto che, per quasi tutte le interpreti citate, il pubblico, oltre che dalle parole e dall’orecchiabilità dei pezzi, è attratto anche dalla personalità delle cantanti, dai costumi, dalle acconciature stravaganti, dai travestimenti e dalle trovate sceniche, dalle copertine dei dischi sempre fantasiose e innovative che hanno fatto di queste artiste delle vere icone. Nelle loro poliedriche e multiformi esibizioni, infatti, non vi era una mera esecuzione vocale di un brano, ma questa si armonizzava con mimica e gestualità, facendo in modo che cantare significasse anche recitare, muoversi sul palco, fare teatro: autentico spettacolo.
Tutto questo, però, sembra bloccarsi a metà degli anni ’80. Per alcune di queste artiste il successo, probabilmente per poca accondiscendenza alle nuove esigenze del mercato discografico, diminuisce, come avviene per Rettore e Anna Oxa; altre, come Nannini, si accostano a una più rassicurante melodia all’italiana; altre, ancora, come Mannoia, addirittura rinnegheranno quelle canzoni, eliminandole dal repertorio e rivolgendosi a una produzione più cantautorale e più rassicurante. Si citi, ad esempio, quella che è forse considerata la canzone-manifesto di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, in cui l’artista, nel testo firmato da Enrico Ruggeri, canta:
Ma potrai trovarci ancora qui
Nelle sere tempestose
Portaci delle rose
Nuove cose
E ti diremo ancora un altro “sì”
Siamo solo nel 1987, a pochissimi anni dalle maliziose Caffè Nero Bollente e L’Aiuola, e ritroviamo la cantante ad aspettare ancora le rose. D’altro canto, la nascente generazione di artiste che si affermava negli anni ’90 – da Giorgia a Laura Pausini, per intenderci ‒ puntava, per lo più, su testi incentrati sui sentimenti, mirando più a virtuosismi vocali che a esibizioni spettacolari o trasgressive. Si affermava un prototipo di cantante-ragazza “acqua e sapone”, il cui repertorio, salvo rarissimi casi, era privo di empito provocatorio.
Non la stessa cosa succede, però, ai colleghi maschi. Con l’affermazione prima del rap, poi del trap, vengono incise canzoni in cui gli interpreti cadono, spesso, nella più becera e violenta volgarità. Accade. Ad esempio, in numerose canzoni di Skioffi, come Yolandi (2017). Qui, fra numerosi insulti, si canta:
Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi
La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi
Se lo vuole forte, io glielo do forte
Forse anche più del dovuto
Le allargo le cosce e spalanco le porte
Il sesso è dunque ampiamente presente ma cessa di essere un’allusione erotica per divenire strumento di violenza e sopraffazione maschile, come i videoclip mostrano apertamente. Ma, lasciando da parte questi esempi, per così dire, estremi, gli artisti sono certamente piu liberi di esprimersi come vogliono quanto ad appetiti sessuali. È ciò che avviene in Che coss’è l’amor del 1992 di Vinicio Capossela:
Che coss’è l’amor
è la Ramona che entra in campo
e come una vaiassa a colpa grosso
te la muove e te la squassa
ha i tacchi alti e il culo basso,
la panza nuda e si dimena
scuote la testa da invasata col consesso dell’amica sua fidata
Più recentemente, in Non amo più (2007), Roberto Vecchioni, facendo riferimento al tema dell’invecchiamento del corpo, dice alla compagna ventenne:
Sarà colpa dello specchio che riflette l’altro uomo che vedevo allora
quello che mi ha fatto un mucchio di promesse e non è stato di parola
Sarà il libro che leggevo, la canzone che credevo mia
o sarà semplicemente che il mio pene non ha più nessuna fantasia
In verità gli esempi, tratti dalla discografia degli artisti che usano questa tipologia di linguaggio e immaginario, sono molteplici e non necessariamente concentrati in un’epoca specifica. A noi servono come punto di partenza per una riflessione che ci porta a evidenziare questa controversia: perché la produzione dei cantanti, contrariamente a quella delle cantanti, ha continuato in questi anni a cantare la sessualità, nei più diversi toni, come un “normale” tema fra altri? E ancora: come suonerebbe oggi – applicando l’elementare regola del Gender role reversal, dell’inversione di genere – per una donna di 60 anni cantare al proprio compagno 20enne: «la mia vagina non ha più nessuna fantasia»? È, certamente, un fatto che, nel 1983, Marcella Bella, forse non rivolgendosi a un 20enne, cantava, in Nell’Aria, scritta da Mogol: «la mia gatta è ancora lì, non parla ma dice sì». Ma sempre in quegli anni. E poi?
Peraltro, facendo riferimento al panorama femminile internazionale, come non citare Madonna, che, in quattro decadi di successo, non ha mai smesso di giocare con la propria sessualità, scardinando convenzioni e convinzioni contro il perbenismo americano e di cui qui, solo a titolo di esempio, fra numerosissimi, cito Erotica del 1992:
Let my mouth go where it wants to
Give it up, do as I say
Give it up and let me have my way
I’ll give you love, I’ll hit you like a truck
I’ll give you love, I’ll teach you how to… ah
I’d like to put you in a trance, all over
Erotic, erotic, put your hands all over my body
Erotic, erotic
***
Lascia che la mia bocca vada dove desidera
Arrenditi, fa come dico
Arrenditi e lasciami fare a modo mio
Ti darò amore, ti colpirò come un carrarmato
Ti darò amore, ti insegnerò a… ah
Mi piacerebbe farti andare in trance, del tutto
Erotico, erotico, toccami dappertutto
Erotico, erotico
E con lei altre star internazionali del calibro di Rihanna, Beyoncé, Kate Perry, Lady Gaga, Britney Spears o Miley Cyrus. Perché queste cantanti, che hanno attraversato le ultime cinque decadi del pop mondiale, non hanno mai rinuciato, sia nella poetica delle proprie canzoni che nelle proprie esibizioni, a quella maliziosa sensualità, in qualche modo tralasciata, per oltre 40 anni, dalle colleghe italiane? Perché, a un certo punto, grosso modo a metà degli anni ’80, tutte le trasgressioni sono scomparse da testi ed esibizioni canore di cantautrici e interpreti italiane?
Appare, oggi, evidente che anche nella musica – come in buona parte dell’industria culturale italiana –, piuttosto che rischiare formule nuove o audaci, si sia preferito scegliere un prodotto neutro, monocorde e non troppo marcato che, non urtando nessuna sensibilità, potesse garantire successi sicuri e immediati. Solo per fare un esempio, l’artista italiana più popolare del 2017, è risultata, secondo la classifica ufficiale della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Laura Pausini con il CD Fatti Sentire. Sul brano di punta, di cui è peraltro autrice, scrive sui social: «Non è detto è un brano che sottolinea l’esigenza di comunicare, di liberare il cuore per permettere alla vita di sorprenderci».
Questi, alcuni fra i versi della canzone:
E non è detto che non provo niente
se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente
e se mi fido della forza di un ricordo caso mai
Prenditi l’ombrello
che sia il riparo sotto la tempesta
se quello che ti devo, è avere il cuore dalla parte giusta.
Ora, fermo restando che le canzoni d’amore sono un genere prevalente nella storia della musica pop nazionale, va detto che, sempre più in Italia, soprattutto negli anni ’90, queste spesso si sono ridotte a un assemblaggio di luoghi comuni – ritmico-stilistici e concettuali – trasferiti da una canzone all’altra, restando nella sostanza immutati ed evidenziando spesso un lessico povero, in cui i sentimenti dominano sul sesso, l’anima sul corpo, l’amore angelicato sulla passione, l’amore sognato sulla carnalità.
Nei pochi casi in cui questo non è successo si è gridato allo scandalo. Si ricordi, per esempio, l’indimenticata Milva, che nel 1993 a Sanremo – curiosamente lo stesso anno in cui Laura Pausini stravinceva con La Solitudine – cantava in Uomini addosso:
Vai che scatta lo scandalo
Tutti pronti coi flash
Cameriere una camera
Uomini sempre pronti
Sono qua!
O, ancora, nel 2009, Iva Zanicchi, sempre al festival che, in Ti voglio senza amore, diceva:
Ti voglio senza amore
Perché mi fa più effetto
Averti dentro un letto
Che pensarti con falso pudore
Però ti tengo stretto
Finché non mi farai gridare sì, sì
In entrambe le circostanze, le due voci storiche della musica italiana, rivendicando il loro diritto al piacere e al sesso, indipendentemente dall’età, furono bersaglio di feroci critiche che ne decretarono addirittura l’eliminazione.
In questo senso è possibile parlare di un’asessualizzazione o, meglio, di una desessualizzazione del modo di porsi delle cantanti e dei loro testi. Dalla metà degli anni ’80 in poi, infatti, è molto difficile trovare una cantante pop italiana che giochi col proprio corpo, in scena, e con la propria sessualità nelle canzoni. Chiosa Ivano Fossati: «Ci si preclude la possibilità di mettere tutto questo al centro della canzone. E forse anche della vita. Niente corpi, niente rughe, ma neanche un po’ di sensualità».
In taluni casi, addirittura, la bellezza o il corpo sono occultati, dando spesso luogo a performance asettiche con l’obiettivo di perseguire un ideale di cantante-ragazza della porta accanto, in cui eccentricità o creatività sono viste come elementi di poca credibilità. Come afferma il giornalista e critico musicale Michele Monina,
il fatto che l’estetica sia stata messa da parte potrebbe essere letta come un passo avanti. Se non fosse che siamo passati direttamente all’opposto, essere bella, esibire il proprio aspetto fisico, giocare con la sensualità, è diventato out. C’è un’intera generazione di cantanti e cantautrici che si sono ingoffite, inseguendo una sorta di anonimato che un po’ cozza con l’idea di popstar.
Questo paradossalmente succede molto nella musica, meno nel cinema e per nulla nella televisione, dove per una showgirl sarebbe assurdo il contrario. E non è un caso che tale opposta evoluzione (o involuzione) si sia verificata in una televisione che, proprio nello stesso periodo, a partire dagli anni Ottanta, subiva l’avvento del berlusconismo, televisivo ancor prima che politico. Si tratta di una coincidenza o di una possibile spiegazione?
Dal “velinismo” delle trasmissioni televisive, tipo Drive-In, fino alle conversazioni private – da bunga bunga – rese poi pubbliche fra il Cavaliere e le “olgettine”, se per un verso si è perfettamente compiuta l’oggettificazione, soprattutto televisiva, della donna, dall’altro, per indignazione e come presa di distanza, proprio per evitare di essere confusi con quella realtà, si è determinata, in ambienti artistico-intellettuali, una sorta di auto-censura, procedendo a un vero e proprio annullamento del corpo, all’eliminazione, anche ironica, di qualsiasi allusione che potesse includere la sessualità o la semplice sensualità della donna. Osserva ancora Monina: «Si è voluta inventare una contrapposizione tra chi usa l’intelletto e chi lavora, produce, come se l’una cosa fosse alternativa all’altra».
Elettra Deiana, esponente del pensiero femminista, identifica proprio in questo fossilizzarsi in due posizioni così opposte un punto di forza per il berlusconismo e, parimenti, l’origine di una reazione fragile da parte della società davanti al problema:
il berlusconismo ha nutrito e si è nutrito – in una misura patologica che non conosce sosta – di quel grande spostamento di senso, che possiamo definire come un vero e proprio passaggio antropologico, dall’accettazione del “limite”, come misura del vivere, accettazione di ciò che mediamente è (o era) percepito come terreno “permesso”, all’affanno bulimico del “tutto e subito”; dal fare cioè i conti con il limite della norma all’insofferenza, all’indifferenza, alla messa in mora e alla derisione della norma, di cui sbarazzarsi.
Anche in musica, le autrici e le interpreti evidentemente non hanno identificato questo limite, questo spartiacque, e, piuttosto che osare, hanno preferito non ribellarsi a questa visione manichei sta: donne “perbene” e donne “permale”.
Ancora una volta, dunque, seppure in modo opposto rispetto a ciò che succede nel mondo televisivo, il corpo, la sessualità, la sensualità della donna ne escono sconfitti, diventando un tabù, come lo stesso Monina senza giri di parole osserva: «il berlusconismo ha privato le donne, comprese quelle dello spettacolo, della libertà di essere donne senza per questo diventare immediatamente oggetto (del desiderio, dello sfizio o della voglia di dominio), uniformandole tutte a pezzi di figa più o meno pregiati».
(fasc. 52, 25 maggio 2024, vol. II)